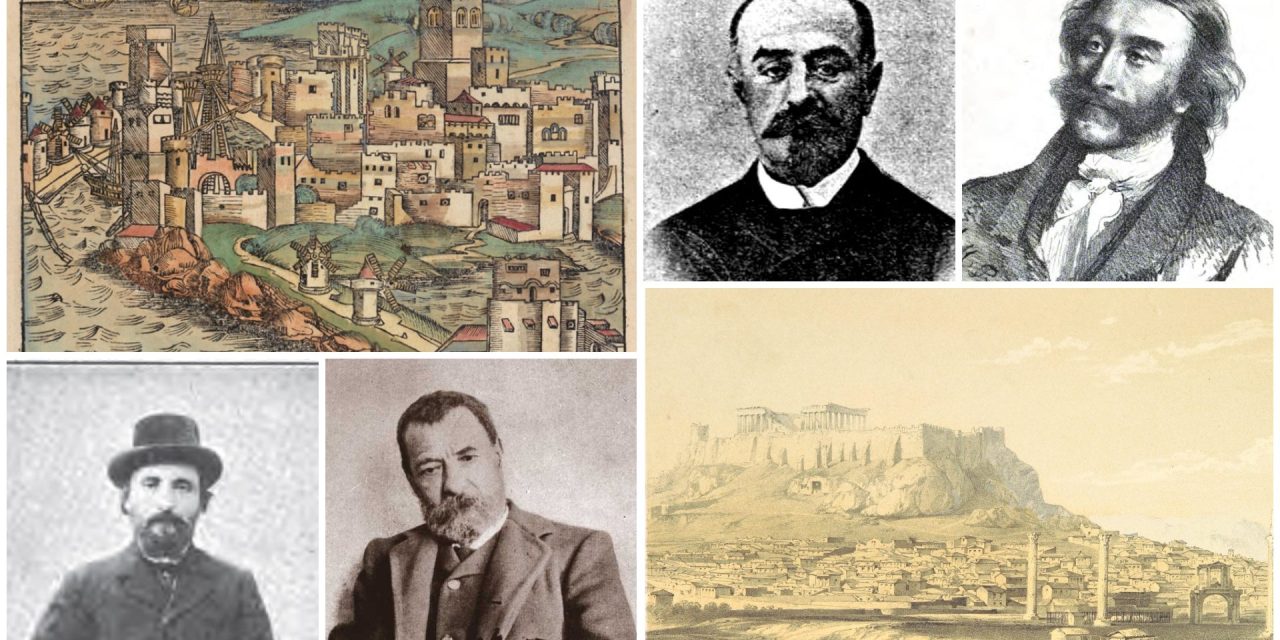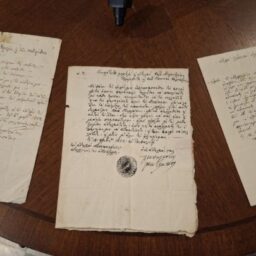Dai dardi avvelenati di Apollo che seminarono la morte nell’accampamento degli achei nell’Iliade di Omero alla descrizione tucididea della Peste di Atene, dal “Decameron” di Boccaccio a “I promessi sposi” di Manzoni, e da “La peste” di Camus alla “Cecità” di Saramago, le malattie contagiose e le loro esplosioni hanno avuto una lunga e costante presenza nella storia della letteratura mondiale.
Le epidemie, e in particolare la peste, che nel loro spietato infierire spopolarono intere regioni e città lasciando il loro indelebile segno sul percorso storico del genere umano, ne popolarono, al contempo, con la loro terribile veemenza e intensità e le loro violente conseguenze, la memoria e l’immaginario collettivo. L’esito fu che col passare del tempo si viene a sviluppare intorno a loro una vera e propria iconografia con i suoi motivi ricorrenti (si ricorda, per esempio, la Danza macabra, il medico della peste con la sua maschera a forma di becco ecc.), un’autentica e peculiare nomenclatura (il monatto, l’untore, il lazzaretto, la quarantena e.a.) e, naturalmente, un folto e variegato corpus di testi letterari che ne ha tramandato la memoria storica attraverso il traslato e universale linguaggio della letteratura. “Infinite variazioni su un solo tema”, così li definisce Fabio Stassi per mettere in rilievo la coerenza e la persistenza con cui la letteratura tornò a più riprese a rielaborare e rivestire di nuovi significati e valenze simboliche l’argomento delle epidemie.
Variazioni magari dovute alla temperie e il contesto storico-culturale in cui nacquero queste opere, agli orientamenti e i fini ideologici di ogni autore, ma anche alle nozioni e conoscenze mediche prevalenti in ogni epoca, all’interpretazione della natura e delle cause di queste epidemie, alla specificità, al decorso e la sintomatologia di ogni malattia contagiosa. Eppure, nonostante queste variazioni e differenze tra di loro, le opere in questione manifestano una serie di luoghi comuni e motivi ricorrenti condivisi. La vasta produzione di opere letterarie che ruotano intorno alla tematica delle epidemie e le somiglianze riscontrate nei relativi testi ebbe come risultato, in ambito anglosassone, la coniazione di un nuovo termine che, appunto, designasse questo “sottogenere” tematico. Si venne a parlare quindi di “plague literature” o “plague writing” (letteratura della peste o delle epidemie in generale).
 Bernt Notke (circa 1435-1509), La Danza macabra (Frammento), Chiesa di San Nicolò a Tallinn/ Fonte: Wikimedia Commons.
Bernt Notke (circa 1435-1509), La Danza macabra (Frammento), Chiesa di San Nicolò a Tallinn/ Fonte: Wikimedia Commons.Una delle principali caratteristiche delle opere raggruppate sotto questo titolo è l’uso dell’epidemia come metafora morale, il che è legato alla concezione che si ebbe delle malattie contagiose in epoche premoderne; ovvero al fatto che esse venivano percepite come un castigo di scaturigine divina, un male che scendeva dall’alto per punire l’empietà, l’hybris o l’immoralità di una collettività o di un singolo. Le epidemie letterarie assumono di conseguenza, fin dall’antichità, una potenza metaforica e allegorica di tipo morale e una funzione rivelatoria atta a evidenziare i fallimenti, i difetti e gli aspetti negativi di una società; diventano così uno strumento nelle mani dell’autore per scandagliare l’animo umano e le sue fragilità. Il loro impatto travolgente, che precipita l’intera collettività in una situazione estrema, mette a nudo la natura umana, scatena comportamenti finora inaccettabili, mette in discussione l’intero ordine dell’essere sociale, e a volte tende a sovvertire la legge, le autorità politiche, sociali o religiose.
A parte questo, però, un altro discrimine delle opere che trattano l’argomento è il ruolo decisivo che i luoghi dell’epidemia ricoprono all’interno della loro trama. I luoghi devastati e afflitti dal male, perlopiù città o isole, si ergono spesso a protagonisti del racconto, a tal punto che sembrano essere loro i veri malati e non i loro abitanti, peraltro ridotti in una massa anonima, depersonalizzati e derubati dei loro connotati per via di un male che si abbatte indiscriminatamente su tutti.
La costante e ricorrente comparsa del tema dell’epidemia sugli atlanti della letteratura mondiale si è verificata anche nel caso greco. Senza pretendere di esaurire l’argomento, la presentazione che segue tenta, attraverso un’esposizione sintetica di alcune delle più rappresentative opere, di tracciare la parabola della tematica dell’epidemia all’interno della letteratura greca moderna, di individuarne i tratti salienti e i mutamenti avvenuti nella sua rappresentazione nel corso dei secoli.
Le “epidemie letterarie” greche dal XV al XIX secolo
Dal punto di vista cronologico, il primo testo della letteratura greca moderna che, pervenuto fino a noi, abbia come tema un’epidemia, è il poema “La peste di Rodi” di Emmanuìl-Manolis Limenitis (gr. “Το Θανατικό της Ρόδου”). Risalente alle origini dell’età moderna, l’opera di Limenitis racconta l’epidemia di peste che tra il 1498 e il 1499 flagellò la città di Rodi, allora sotto il controllo dei Cavalieri Ospitalieri. Prendendo, assai probabilmente, a modello la narrazione tucididea della famosa peste ateniese, l’autore fa la cronaca dell’irrompersi e del diffondersi della malattia e offre una descrizione vivida delle sofferenze e dei comportamenti umani osservati durante il suo imperversare. In linea con una concezione punitiva delle malattie infettive, dominante al suo tempo, Limenitis attribuisce il male ad una fonte “celeste” incolpando e biasimando la condotta, la corruzione morale e i peccati dei suoi conterranei per aver attirato l’ira divina; di qui anche il tono parenetico e moraleggiante che permea il suo poema e che, accostato da descrizioni nostalgiche della prosperità perduta, richiama i cittadini di Rodi sulla retta via.


Una riflessione e un atteggiamento critici e a tratti polemici verso il mondo della politica e l’apparato governativo del Paese sottende e anima anche il racconto “Η ξένη του 1854” [La straniera del 1854] dello scrittore e giurista Emmanuìl Likùdis. Uscito nello stesso anno, il racconto di Likùdis si incentra sull’epidemia del colera che colpì Atene nel 1854 decimando una gran parte della sua popolazione (si stima che dai 20.000 abitanti della città morirono circa 1.000). Il male, che ebbe il suo primo focolaio nella zona portuale del Pireo, fu portato dalla flotta franco-britannica -di qui anche il titolo “La straniera” del racconto-, la quale, in un episodio legato al contesto geopolitico della guerra di Crimea (1853-1856), vi si era recata bloccando Pireo e, in seguito, occupando per un triennio la capitale greca (1854-1857), al fine di costringere il re Ottone alla neutralità e di impedirgli di approfittare della crisi in Crimea per ottenere ingrandimenti territoriali a spese del loro allora alleato, l’Impero ottomano. Il racconto di Likùdis, quindi, narra dell’epidemia e della sua esplosione dipingendo un vivo affresco della vita quotidiana entro le mura della città afflitta. La malattia rappresenta qui l’ennesima, e più grave, disgrazia che viene a sovrapporsi a quella dell’occupazione e ad altre più vecchie che da anni perseguitano il Paese. La sua comparsa viene collegata al predominio straniero sulla Grecia. Per questa situazione l’autore prende di mira la classe dirigente e ne critica l’incapacità di formulare una propria ed autonoma politica, e la sua docilità nell’eseguire i dettami imposti dalle potenze straniere.

Per via dell’argomento trattato e del periodo storico a cui si riferisce, cioè l’epidemia del colera del 1854, viene qui presentata, sebbene fosse pubblicata nel 1901, anche il breve racconto “Η Χολεριασμένη” [L’affetta da colera] di Alexandros Papadiamantis, uno dei maggiori scrittori della letteratura greca, esponente di punta della corrente della cosiddetta “ithografia”, la versione greca del naturalismo francese e del verismo italiano. Il racconto ha la forma di una testimonianza orale rilasciata all’autore molti anni dopo i fatti narrati da una certa Rini Eleftherena, “anziana e venerabile ateniese”, e da lui riportata in prima persona. Signora Rini, lei stessa ammalata di colera in quel periodo, fornisce un quadro della situazione e dei comportamenti umani sorti all’indomani del manifestarsi dell’epidemia nella capitale: il trionfo dell’avidità e della speculazione spregiudicata, lo sfruttamento da uomo a uomo, e l’affermarsi nella popolazione di atteggiamenti egoistici, esemplificati in modo drammatico nell’abbandono di Rini, rimasta sola con la figlia neonata, da suo marito. A questo triste inventario dell’umanità si sottraggono solo un vicino di casa, il clero, il popolo in senso generale, e re Ottone che non scappò dalla città per salvarsi. Del resto, il sentimento di intolleranza verso l’occupazione franco-britannica appare chiaro anche in questo racconto, mentre altrettanto presente è l’aspetto religioso, ravvisabile nelle convinzioni della protagonista che attribuisce il merito dell’eradicazione della malattia ad una processione organizzata a tale proposito pochi giorni prima della fine dell’epidemia.
 Atene intorno al 1854, Illustrazione tratta dal libro di Lady Catherine Tobin “Shadows of the East; or, slight sketches of scenery, persons and customs, from observations during a tour in 1853 and 1854, in Egypt, Palestine, Syria, Turkey, and Greece. With maps and illustrations” (1855)/ Fonte: Wikimedia Commons.
Atene intorno al 1854, Illustrazione tratta dal libro di Lady Catherine Tobin “Shadows of the East; or, slight sketches of scenery, persons and customs, from observations during a tour in 1853 and 1854, in Egypt, Palestine, Syria, Turkey, and Greece. With maps and illustrations” (1855)/ Fonte: Wikimedia Commons. Georghios Surìs (a sinistra) e Alexandros Papadiamantis (a destra) / Fonte: Wikimedia Commons.
Georghios Surìs (a sinistra) e Alexandros Papadiamantis (a destra) / Fonte: Wikimedia Commons.
Infine, pochi anni prima, nel 1884, era uscita sullo stesso argomento la commedia “L’epidemia” (Η επιδημία) del grande poeta satirico, drammaturgo ed editore Georghios Surìs, nato nel 1853 e morto, per ironia della sorte, di “Spagnola” nel 1919. A differenza dei testi finora esposti, nell’atto unico di Surìs, che si svolge per intero in un salotto borghese, la malattia (che, come veniamo a sapere, trattasi di un’epidemia di tifo addominale) non entra mai in scena e nessuno dei personaggi ne contrae l’infezione. In effetti essa fa da cornice e porta avanti la trama, ma, in sostanza, sembra che serva sia ai personaggi che all’autore soltanto come pretesto; agli uni per realizzare i loro – a volte riprovevoli – desideri, all’altro per mettere in scena una satira dissacrante contro l’avidità, il bigottismo e l’ipocrisia del modo di vita e dei costumi borghesi.
Fonti principali:
s.d.